La profetessa si avvia verso il tempio, desiderando fare, come d'uso, invocazioni agli dèi. Ma all'improvviso, scorgendo le Erinni che dormivano intorno a Oreste, è colta da timore.
Infatti le Erinni si destano (διεγείρονται, presente medio-passivo) poiché l'apparizione (εἴδωλον)
di Clitennestra si presenta (ἐφίσταται, presente medio-passivo) e, rimproverandole (μεμφόμενον, participio presente medio), le sveglia (ἀνεγείρει, presente attivo). ...
LA TRADUZIONE CONTINUA QUI
Analisi grammaticale dei principali verbi
πρόεισιν – 3ª persona singolare, indicativo presente attivo, verbo πρόειμι
θέλουσα – participio presente attivo, femminile nominativo singolare, verbo θέλω
ποιεῖν – infinito presente attivo, verbo ποιέω
ἰδοῦσα – participio aoristo secondo attivo, femminile nominativo singolare, verbo ὁράω
καθευδούσας – participio presente attivo, femminile accusativo plurale, verbo καθεύδω
ἐκπλήττεται – 3ª persona singolare, indicativo presente medio-passivo, verbo ἐκπλήσσω
διεγείρονται – 3ª persona plurale, indicativo presente medio-passivo, verbo διεγείρω
ἐφίσταται – 3ª persona singolare, indicativo presente medio-passivo, verbo ἐφίστημι
μεμφόμενον – participio presente medio-passivo, neutro accusativo/nominativo singolare, verbo μέμφομαι
ἀνεγείρει – 3ª persona singolare, indicativo presente attivo, verbo ἀνεγείρω
φησίν – 3ª persona singolare, indicativo presente attivo, verbo φημί
ἔπραξα – 1ª persona singolare, indicativo aoristo primo attivo, verbo πράσσω
ἀτιμάζετε – 2ª persona plurale, indicativo presente attivo, verbo ἀτιμάζω
οὐκ ἀτιμάζονται – 3ª persona plurale, indicativo presente medio-passivo, verbo ἀτιμάζω
ὁρῶσα – participio presente attivo, femminile nominativo singolare, verbo ὁράω
ἀκούουσα – participio presente attivo, femminile nominativo singolare, verbo ἀκούω
σκέπτεται – 3ª persona singolare, indicativo presente medio-passivo, verbo σκέπτομαι
διαλέγεται – 3ª persona singolare, indicativo presente medio-passivo, verbo διαλέγομαι
ἐφόνευσε – 3ª persona singolare, indicativo aoristo primo attivo, verbo φονεύω
διεπράξω – 2ª persona singolare, indicativo aoristo medio, verbo διαπράσσω
εἶ – 2ª persona singolare, indicativo presente attivo, verbo εἰμί
περιστρέφεις – 2ª persona singolare, indicativo presente attivo, verbo περιστρέφω
προὔτεινέ – 3ª persona singolare, indicativo imperfetto attivo, verbo προτείνω
ὑπομιμνήσκουσα – participio presente attivo, femminile nominativo singolare, verbo ὑπομιμνήσκω
θηρωμένη – participio presente medio-passivo, femminile nominativo singolare, verbo θηράω
οὐκ ἠλέησας – 2ª persona singolare, indicativo aoristo primo attivo, verbo ἐλεέω
γέγονας – 2ª persona singolare, indicativo perfetto attivo, verbo γίγνομαι
διδοὺς – participio presente attivo, maschile nominativo singolare, verbo δίδωμι
πέπονθεν – 3ª persona singolare, indicativo perfetto attivo, verbo πάσχω
πράττειν – infinito presente attivo, verbo πράσσω
ἐστι – 3ª persona singolare, indicativo presente attivo, verbo εἰμί.
SPIEGAZIONE DI QUESTO BRANO
Questo è un passo tratto dagli Scholia antichi all'"Eumenidi" di Eschilo, una delle tre tragedie che compongono l'Orestea, capolavoro assoluto del teatro attico del V secolo a. C. Gli scoliasti, eruditi dell'antichità e del Medioevo, avevano il compito di commentare, spiegare e tramandare i testi classici: in questo caso, il loro obiettivo è guidare il lettore nella comprensione di un episodio particolarmente denso di significato mitologico e morale.
Il brano si sofferma su un momento fondamentale dell'azione tragica: l'ingresso della profetessa – la Pizia, sacerdotessa di Apollo – nel tempio di Delfi, dove si imbatte in una scena terrificante e carica di tensione. La donna, secondo l'usanza (ὡς ἔθος), sta per compiere le invocazioni agli dèi, ma rimane sconvolta dalla visione delle Erinni, le divinità della vendetta, che circondano il corpo dormiente di Oreste.
Lo spettro di Clitennestra appare alle Erinni, rimproverandole di non vendicare la sua uccisione con la stessa severità con cui puniscono altri crimini. È una scena fortemente simbolica: la giustizia arcaica, fondata sulla vendetta e sul sangue, entra in crisi, e il passaggio alla giustizia razionale e civile – che avverrà nel corso della tragedia – si profila all'orizzonte.
Il linguaggio dello scoliaste è sobrio ma preciso, e mira a chiarire i riferimenti mitologici, le emozioni dei personaggi e il significato morale della scena. Vi è attenzione al pathos (come nel lamento di Clitennestra per la propria sorte) e alle implicazioni etiche del matricidio: si pone infatti il problema se Oreste, pur colpevole di un atto atroce, possa essere giustificato dal contesto di ingiustizia precedente.
Questo testo, sebbene sia un commento, rivela un'interpretazione viva e partecipe del dramma, e ci permette di vedere come gli antichi lettori – non molto diversi da noi – cercassero di comprendere i conflitti, i dilemmi morali e la complessità dei sentimenti messi in scena da Eschilo. È un esempio straordinario di ricezione antica del teatro tragico, e una finestra sulla riflessione etica e religiosa della cultura greca.
La profetessa di Apollo, le Erinni e Oreste - pagina 486 numero 29 ELLENISTI volume 2 (VERSIONE GRECO)
Ho bisogno di questa versione quanto prima !!
- Allegati
- lucisis
Risposte:
- Site Admin
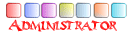
Copyright © 2007-2025 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2025 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.
