Apologia di socrate PLATONE ANALISI e ACCUSE
L’APOLOGIA DI SOCRATE
Analisi
Platone ci descrive in questo libro la difesa del suo maestro Socrate durante il processo per la sua condanna a morte. Platone esalta notevolmente la figura del suo maestro, che anche in una situazione così estrema non rinnega la sua ideologia. L'Apologia vuole quindi essere anche una sorta di presentazione del personaggio di Socrate, del suo pensiero e del suo stile di vita.
Il libro si articola principalemente in trei fasi:
• La prima, dove Socrate confuta tutte le cause che vengono mosse contro di lui, partendo da quelle più antiche a quelle fatte di recente.
• La seconda fase, dove si assisterà alla dichiarazione di colpevolezza e alla richiesta di pena di morte, dove Socrate proporrà una pena alternativa.
• La terza e ultima fase dove Socrate dirà ai giudici che egli stesso era convinto dell’esito della sentenza, in quanto non sarebbe stato giusto né esiliarlo, né lasciarlo libero con la condizione di non incorrere più in quelli che erano i reati contestati.
Gli accusatori più recenti di Socrate saranno Meleto, Anito, Licone, nominati e chiamati in causa dallo stesso Socrate durante il processo.
Le accuse saranno quelle di empietà, per aver infatti rinnegato gli dei della città e aver provato a introdurne dei nuovi, e di corruzione dei giovani che seguivano la sua dottrina.
Socrate rimase molto impressionato dall’abilità oratoria dimostrata dai suoi accusatori, non nuovi al mondo della politica della città.
Inizia così la sua difesa spiegando ai giudici di non essere dotato della retorica propria dei Sofisti e perciò si limiterà a perorare la propria difesa usando modesti mezzi linguistici, quali quelli che usava nel linguaggio comune. Prega loro di non badare allo stile o alla forma, ma solo alla sostanza di ciò che si appresta a dire.
LE ACCUSE
Gli Accusatori
Socrate ritiene che le accuse più antiche siano anche le più gravi e pesanti perché c’è stato il tempo per diffonderle e insediarle nelle menti delle persone e perché sono mosse da interi gruppi di cittadini, ma da nessuno in particolare.
Gli accusatori più antichi presentano Socrate come un filosofo naturalista (“indaga sulle cose celesti e su quelle che sono sotto terra”) e come un sofista (“rende migliori anche le ragioni peggiori e si fa pagare per i sui insegnamenti”). Il maestro però per concentrarsi sull’uomo abbandonò la metafisica (solo questo ha in comune con i Sofisti), tanto meno si fa pagare.
Socrate pensa che antiche ostilità siano la causa portante di tutte le accuse che lo hanno portato in tribunale, ed è per questo che inizia a difendersi proprio da queste.
Gli accusatori recenti sono invece: Meleto, Anito e Licone: accusano Socrate di corruzione dei giovani, di non riconoscere gli dei della città e di volerne introdurre di nuovi.
In questa seconda parte del discorso di difesa, Socrate intraprende una sorta di dialogo direttamente con il suo principale accusatore. Attraverso un fitto interrogatorio, come solitamente faceva, Socrate smonta una ad una le accuse costringendo il suo avversario ad ammetterne indirettamente l’infondatezza.
L’accusa di corruzione dei giovani scaturisce dal fatto che durante i suoi dialoghi il maestro era seguito da molti giovani che desideravano seguire i suoi insegnamenti e cercavano di imitarlo. Socrate comincia col discutere intorno all’educazione dei giovani ed in particolare si chiede a chi debba essere affidato questo compito; con alcune domande costringe Meleto ad affermare che sia compito di ogni ateniese formare culturalmente i giovani, ma il filosofo è proprio colui che minaccia la sua integrità. Aggiunge inoltre di non possedere alcuna verità da insegnare, perché ognuno ha già in sé una propria verità; il suo compito è semplicemente quello di stimolare l’interlocutore per aiutarlo a (come disse Socrate) “partorirla” (attraverso la maieutica socratica).
L’imputazione di empietà invece si articola in due accuse: quella di ateismo, viene contraddetta e annullata dalla successiva legata all’introduzione di nuove divinità. È detto che Socrate non creda agli dei della città. Socrate raccontava di sentire dentro sé la voce di un demone che, da quando aveva accolto la rivelazione dell’oracolo di Delfi, suggerisce e giudica le sue azioni. Il demone più che come un essere divino può essere interpretato come un espressione di una forte coscienza interiore. In ogni caso il ‘segno demoniaco’ che avverte Socrate è ben lontano dalla nuova divinità che voleva far credere Meleto.
Analisi
Platone ci descrive in questo libro la difesa del suo maestro Socrate durante il processo per la sua condanna a morte. Platone esalta notevolmente la figura del suo maestro, che anche in una situazione così estrema non rinnega la sua ideologia. L'Apologia vuole quindi essere anche una sorta di presentazione del personaggio di Socrate, del suo pensiero e del suo stile di vita.
Il libro si articola principalemente in trei fasi:
• La prima, dove Socrate confuta tutte le cause che vengono mosse contro di lui, partendo da quelle più antiche a quelle fatte di recente.
• La seconda fase, dove si assisterà alla dichiarazione di colpevolezza e alla richiesta di pena di morte, dove Socrate proporrà una pena alternativa.
• La terza e ultima fase dove Socrate dirà ai giudici che egli stesso era convinto dell’esito della sentenza, in quanto non sarebbe stato giusto né esiliarlo, né lasciarlo libero con la condizione di non incorrere più in quelli che erano i reati contestati.
Gli accusatori più recenti di Socrate saranno Meleto, Anito, Licone, nominati e chiamati in causa dallo stesso Socrate durante il processo.
Le accuse saranno quelle di empietà, per aver infatti rinnegato gli dei della città e aver provato a introdurne dei nuovi, e di corruzione dei giovani che seguivano la sua dottrina.
Socrate rimase molto impressionato dall’abilità oratoria dimostrata dai suoi accusatori, non nuovi al mondo della politica della città.
Inizia così la sua difesa spiegando ai giudici di non essere dotato della retorica propria dei Sofisti e perciò si limiterà a perorare la propria difesa usando modesti mezzi linguistici, quali quelli che usava nel linguaggio comune. Prega loro di non badare allo stile o alla forma, ma solo alla sostanza di ciò che si appresta a dire.
LE ACCUSE
Gli Accusatori
Socrate ritiene che le accuse più antiche siano anche le più gravi e pesanti perché c’è stato il tempo per diffonderle e insediarle nelle menti delle persone e perché sono mosse da interi gruppi di cittadini, ma da nessuno in particolare.
Gli accusatori più antichi presentano Socrate come un filosofo naturalista (“indaga sulle cose celesti e su quelle che sono sotto terra”) e come un sofista (“rende migliori anche le ragioni peggiori e si fa pagare per i sui insegnamenti”). Il maestro però per concentrarsi sull’uomo abbandonò la metafisica (solo questo ha in comune con i Sofisti), tanto meno si fa pagare.
Socrate pensa che antiche ostilità siano la causa portante di tutte le accuse che lo hanno portato in tribunale, ed è per questo che inizia a difendersi proprio da queste.
Gli accusatori recenti sono invece: Meleto, Anito e Licone: accusano Socrate di corruzione dei giovani, di non riconoscere gli dei della città e di volerne introdurre di nuovi.
In questa seconda parte del discorso di difesa, Socrate intraprende una sorta di dialogo direttamente con il suo principale accusatore. Attraverso un fitto interrogatorio, come solitamente faceva, Socrate smonta una ad una le accuse costringendo il suo avversario ad ammetterne indirettamente l’infondatezza.
L’accusa di corruzione dei giovani scaturisce dal fatto che durante i suoi dialoghi il maestro era seguito da molti giovani che desideravano seguire i suoi insegnamenti e cercavano di imitarlo. Socrate comincia col discutere intorno all’educazione dei giovani ed in particolare si chiede a chi debba essere affidato questo compito; con alcune domande costringe Meleto ad affermare che sia compito di ogni ateniese formare culturalmente i giovani, ma il filosofo è proprio colui che minaccia la sua integrità. Aggiunge inoltre di non possedere alcuna verità da insegnare, perché ognuno ha già in sé una propria verità; il suo compito è semplicemente quello di stimolare l’interlocutore per aiutarlo a (come disse Socrate) “partorirla” (attraverso la maieutica socratica).
L’imputazione di empietà invece si articola in due accuse: quella di ateismo, viene contraddetta e annullata dalla successiva legata all’introduzione di nuove divinità. È detto che Socrate non creda agli dei della città. Socrate raccontava di sentire dentro sé la voce di un demone che, da quando aveva accolto la rivelazione dell’oracolo di Delfi, suggerisce e giudica le sue azioni. Il demone più che come un essere divino può essere interpretato come un espressione di una forte coscienza interiore. In ogni caso il ‘segno demoniaco’ che avverte Socrate è ben lontano dalla nuova divinità che voleva far credere Meleto.
- nuovo iscritto

Risposte:
- Site Admin
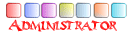
Copyright © 2007-2025 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2025 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.
