TUTTA LA TRADUZIONE LA TROVI QUI
/versioni-virgilio/virgilio-bucoliche-ecloga-i.html
QUESTO è IL TESTO
Meliboeus: at nos hinc alii sitientis ibimus Afros,
pars Scythiam et rapidum cretae veniemus Oaxen
et penitus toto divisos orbe Britannos.
en umquam patrios longo post tempore finis
pauperis et tuguri congestum caespite culmen,
post aliquot, mea regna, videns mirabor aristas?
impius haec tam culta novalia miles habebit,
Barbarus has segetes. en quo discordia civis
produxit miseros; his nos consevimus agros!
insere nunc, Meliboee, piros, pone ordine vites.
ite meae, felix quondam pecus, ite capellae.
non ego vos posthac viridi proiectus in antro
dumosa pendere procul de rupe videbo;
carmina nulla canam; non me pascente, capellae,
florentem cytisum et salices carpetis amaras.
Noi, invece (At), di qui (hinc) andremo alcuni (alii) fra gli Afri assetati (sitientis, sitientes), altri (pars) in Scizia e perverremo all’Oasse fangoso (rapidum cretae, che trascina fango) e ai Britanni del tutto (penitus) separati dal resto del mondo (toto orbe, iperbato). Ah! Dopo lungo tempo (longo post tempore, anastrofe) tornerò mai (umquam) ad ammirare (mirabor) il suolo della patria (patrios finis, fines) e il tetto (culmen) coperto (congestum) di zolle erbose (caespite) della (mia) povera capanna (pauperis et tuguri, anastrofe di et), mio regno, vedendoli (videns) dietro alquante spighe (aristas)? Un empio soldato (Impius miles, iperbato) avrà questi maggesi (haec novalia) tanto coltivati (tam culta), un barbaro queste messi (has segetes)? Ecco, dove (quo) la discordia ha condotto i miseri cittadini (miseros civis, cives): per costoro (his) noi abbiamo seminato (consevimus) i campi! Innesta (Insere) ora i peri (piros), Melibeo; disponi in filari (pone in ordine) le viti (vitis, vites)! Andate, o mie caprette, gregge (pecus) un tempo (quondam) felice, andate! Non io d’ora in poi (posthac), sdraiato (proiectus) in una grotta verdeggiante (viridi in antro, anastrofe e iperbato), vi vedrò sospese lontano (procul) a una rupe coperta di rovi (dumosa de rupe, anastrofe e iperbato); non canterò (canam) nessuna canzone (nulla carmina); non brucherete (carpetis), caprette, il citiso in fiore (florentem cytisum) e i salici amari (salices amaras, iperbato), mentre io vi conduco al pascolo (me pascente).
Tityrus Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem
fronde super viridi. sunt nobis mitia poma,
castaneae molles et pressi copia lactis,
et iam summa procul villarum culmina fumant
maioresque cadunt altis de montibus umbrae
Qui, tuttavia, potevi riposare (requiescere) con me questa notte (hanc noctem, iperbato) su verdi frasche (fronde super viridi, anastrofe): ho frutti maturi (mitia poma sunt nobis, sum pro habeo), morbide castagne (molles castaneae) e abbondante (copia) formaggio (pressi lactis), e già lontano fumano le sommità dei tetti (summa culmina) dei casolari (villarum) e più grandi cadono le ombre dagli alti monti (altis de montibus, anastrofe).
leggenda figure retoriche:
- iperbato: lontananza dell’aggettivo dal suo corrispondente sostantivo
- anastrofe: preposizione posta in mezzo tra aggettivo e sostantivo
- poliptoto: ripetizione di termini con desinenze diverse ad inizio verso o frase
- anafora: ripetizione di termini uguali ad inizio verso o frase
----------
Veniemus - principale
videns - partic congiunto
mirabor - principale
habebit - principale
produxit - principale valore esclamativo
conscevimus - principale
insere - principale
pone - principale
ite...ite - principali
pendere - infinitiva
videbo - principale
carpetis - principale
poterai - principale
requiescere - infinitiva
sunt - principale
fumant - principale
cadunt - principale
Afros: metonimia per africani
dal Sud si passa al Nord con la Scizia (nome di regione: variatio rispetto a Afri nome di popolo): col che, considerati Parti e Germani, si sono toccati i quattro punti cardinali: i Britanni invece sono reputati fuori dal mondo , ultimos
Tityrus forma dorica del gr. satyros ("satiro", cioè un semidio dei boschi)
Oaxen
sembra variante o confusione per Oxus, fiume asiatico (odierno Amu affluente del lago d'Aral) qui associato per epifrasi (aggiunta) alla Scizia - regione che si estendeva dall'Asia centrale ai territori a Nord del Caspio, e che era sentita come settentrionale - oppure è un fiume cretese (infatti c'è chi intende "il rapido Oasse di Creta") che però guasta la simmetria dei quattro punti cardinali: e a rigore non si può escludere neppure un voluto bisticcio linguistico su cretae. Molti commentatori pensano che i quattro punti cardinali siano tutti contenuti nei vv. 64-66: Afri a Sud, Scizia a Nord, Oasse a Est e Britanni a Ovest. Le perifrasi geografiche a base di riferimenti dotti erano ricercate dalla poesia ellenistica
Aristas
passo di tormentata interpretazione, a causa dell'incerto senso di post aliquot aristas. Qualcuno intende: "dopo alcuni anni (lett. 'dopo qualche raccolto di grano') contemplerò la patria ecc.?"; a questa spiegazione si oppone, oltre all'assenza di riscontri della metafora arista = annus, soprattutto quell'aliquot che smorza e contraddice Longo post tempore di appena due versi prima. Secondo altri post è avverbio ("in seguito") e aliquot aristas è ogg. di mirabor insieme con finis e culmen ("ammirerò la patria, il tetto e qualche spiga?"); tesi indebolita dall'improbabile valore avverbiale di post immediatamente seguito da aliquot e dall'assenza di congiunzione fra culmen e aristas, diversamente che fra finis e culmen. Qualcuno fa di aliquot aristas l'ogg. di mirabor separato da videns: "vedendo ecc., mi meraviglierò di poche spighe", per l'incuria del soldato ch'è il nuovo padrone della terra; ma aliquot è troppo tenue per equivalere decisamente a paucas. Altri poi separano in ogni caso videns, dandogli come ogg. mea regna, che non sarebbe pertanto apposizione degli ogg. di mirabor ("vedendo il mio regno, ammirerò la patria ecc."). L'interpretazione da noi accolta intende post in senso spaziale ("dietro") e mea regna come apposizione preferibilmente solo di aristas: la meraviglia è tutta di chi rivede i propri luoghi dopo tanto tempo; e incontra prima la distesa delle patrie terre, poi, avvicinandosi, il campicello di grano (piccola proprietà, forse depauperata da anni di negligenza), dietro al quale ecco apparire la modesta capanna.
Impius
perché macchiato di sangue fraterno nelle guerre civili, anzi perché la guerra è sempre impia; pius è invece l'agricola, rispettoso degli dèi e della natura.
Novalia
Maggesi ossia campi lasciati a riposo per un anno, quindi particolarmente fertili; al contrario segetes sono i campi seminati (o che stanno per esserlo). Nel v. 70 nota la ricercata coincidenza fra arsi e accenti grammaticali, che ne accentua la discorsività e il realismo: sono le parole di un coltivatore italico espropriato.
Barbarus: richiama impius: "barbaro" è il soldato per la sua violenza e rozzezza, e perché come tale si comporta con la terra, che non sa trattare e rispetto alla quale è" straniero" (tale il senso originario di barbarus: e qualcuno pensa anche a una provenienza gallica, germanica. iberica dei veterani assegnatari di terre).
Discordia
è la guerra civile con i successivi espropri intervenuti dopo Filippi (42 a.C.)
Nunc
è detto con amarezza e sarcasmo: l'innesto di alberi da frutto e la piantagione di vigneti richiedono particolare perizia e dedizione, di cui Melibeo non potrà più dar prova.
Non
l'accostamento non ego vos ("non io voi") illumina subito pateticamente la scena che sta per essere rievocata: l'idillio che coinvolgeva pastore e caprette è finito per sempre; quanto alla scena, Melibeo vi compare nel medesimo atteggiamento attribuito prima a Titiro (lentus in umbra, v. 4 e v. 1; frigus captabis opacum, v. 52), sdraiato all'imboccatura di una grotta fresca e verdeggiante, mentre guarda le caprette lontane: esse "pendono" dalla rupe sia perché è loro uso arrampicarsi arditamente in luoghi scoscesi, sia perché tale è l'effetto ottico per Melibeo steso a terra.
Poteras
come l'it. "potevi" indica una possibilità non ancora esclusa; le castagne (molli perché cotte) ci introducono a un'atmosfera autunnale, la cui malinconia è ribadita dall'ora serotina e musicalmente resa dalla prevalenza di u in arsi negli ultimi due versi. La partenza dell'esule è ancor più struggente perché al tramonto il fumo lontano dei camini evoca l'idea di una casa propria, foss'anche un tugurio, che Melibeo partente non ha più: sorge allora nell'ultima battuta di Titiro la poesia della solidarietà fra umili, l'offerta d'un giaciglio e di un pasto frugale.
Culmina
Finale ispirato a Teocrito (dove Polifemo invita Galatea a passare la notte da lui, elencandole un po' prolissamente le bontà di casa) ma liberamente rielaborato: questi versi toccano nuove altezze poetiche, suggerendo la vastità degli spazi (summa, procul, culmina, maiores, altis), nei quali s'intravedono i comignoli fumanti per il pasto serale e si assiste all'allungarsi delle ombre al tramonto;
1 ecloga di VirgilioTitiro e Melibeo FIGURE RETORICHE
Ciao a tutti!
Mi servirebbe per domani pomeriggio la costruzione,l'analisi del testo e le figure retoriche della 1 egloga di Virgilio "Titico e Melibeo";dal verso 64 a 84.
titolo del libro:"Auctorum lectio 2"
inizio:At nos hinc alii sitientis ibimus Afros...
fine:...maioresque cadunt altis de montibus umbrae.
Ho un'interrogazione in classico latino!!!!!!!!!!!!!
Grazie in anticipo
- nuovo iscritto

Risposte:
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
- Site Admin
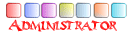
Grazie mille 
Sei unica
Sei unica
- nuovo iscritto

Copyright © 2007-2025 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2025 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.
